Al bancone del bar: “un orzo, per favore”. Il barista domanda: “normale?”. D’istinto rispondo di sì, poi, incuriosita, chiedo: “Perché? Come lo fa speciale?”
Parte immediatamente un’associazione mentale. Non posso fare a meno di ripensare a un dibattito sulla correttezza dell’utilizzo di certi termini a cui ho assistito a un convegno sul diversity management. Mantengo ancora molto vivo il ricordo di quello “scontro verbale” sull’uso del termine normale…
Nel mio dizionario mentale il contrario di normale è speciale, non diverso… non ho bisogno di ragionarci, il termine è stampato nella mia mente alla voce “contrario di normale”. E allora mi chiedo: E’ corretto parlare di gestione della diversità?
Questo non vuole essere un articolo sulla diversity, ma una provocazione per chi, come noi, lavora da anni sui cosiddetti “gender diversity” e “age management”, per fermarci un attimo a riflettere sull’appropriatezza del linguaggio che usiamo nelle organizzazioni.
I filosofi da sempre sostengono che le parole danno forma ai pensieri. Il modo in cui definiamo le cose ne visualizza l’immagine, dà l’idea di come le percepiamo, le viviamo…
Cosa significa diverso? La Treccani ci dà la seguente definizione:
Divèrso agg. e s. m. [lat. divĕrsus, propr. part. pass. di divertĕre «deviare», comp. di di(s)-1 e vertĕre «volgere»]. – 1. agg. Propr., volto in altra direzione, in senso proprio e fig., quindi anche alieno, lontano. Di qui i significati più comuni: a. Che non è uguale né simile, che si scosta per natura, aspetto, qualità da altro oggetto, o che è addirittura altra cosa (si distingue perciò da differente, in quanto la differenza può essere anche parziale e per singoli, talora minimi, aspetti, mentre la diversità è per lo più totale).
Il concetto di diversità implica un riferimento, un paragone. Essere diverso da… Da chi? Da cosa?
Sempre dalla Treccani: 3. s. m. (f. -a) Persona che, per qualche aspetto, carattere o manifestazione, esce da quella che è tradizionalmente considerata la condizione «normale», cioè omosessuali, disabili fisici o psichici, ecc.
Nella lingua italiana il contrario di diverso è normale. La diversità è qualcosa che si contrappone alla normalità. E, inevitabilmente, almeno nella mia mente, si riveste di un’accezione negativa. E’ di uso comune l’espressione “riportare a condizioni di normalità”, come se la normalità fosse una condizione a cui tendere. Quindi diverso indica qualcosa o qualcuno che dovrebbe aspirare alla normalità, colmando una mancanza o cambiando qualcosa di sè. Ma allora la diversità deve far riferimento a una minoranza perché altrimenti sarebbero i normali a essere diversi dal modello imperante.
E allora diventa ancora più forte l’esigenza di capire se usiamo il termine corretto…
Molti ironizzano sull’esistenza di 7 donne per ogni uomo sulla terra. Al di là delle battute, in Italia ci sono circa 94 uomini ogni 100 donne*. Le donne non sono affatto una minoranza e in molte aziende sono la maggioranza, almeno fino a un certo inquadramento contrattuale. E allora, definirle implicitamente minoranze, non è già un modo per ridurne il potere, almeno agli occhi di se stesse? Ma consideriamo anche altre “diversità”. L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione ed è calcolato come il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2016 l’indice di vecchiaia per l’Italia dice che ci sono 161,4 anziani ogni 100 giovani*. La popolazione sta invecchiando e anche quella aziendale segue lo stesso trend con l’allungamento della vita lavorativa dalla riforma pensionistica in poi. Allora in questo caso il normale è chi sta sopra o sotto una certa soglia d’età? Considerando invece le persone con culture diverse dalla nostra, nel corso dell’ultimo decennio la popolazione straniera residente in Italia è triplicata*.
Se sommiamo le diversità in azienda, non è forse vero che donne, over 50, persone provenienti da altre culture ecc… messe insieme costituiscono la maggioranza della popolazione? Definirle col termine diverso non crea già un pregiudizio in partenza? Le mostriamo agli altri (“i normali”) come fasce di popolazione da “tutelare” perché diverse e, quindi, in difficoltà. Nella migliore delle ipotesi possiamo generare negli altri un sentimento di compassione, nella peggiore ostilità.
Qualche mese fa è stato pubblicato un articolo sulla Harvard Business Review sul perché molti programmi per la diversity falliscono. Spesso si rischia di alimentare il pregiudizio anziché rimuoverlo. Il linguaggio è uno dei fattori che più di altri genera e alimenta pregiudizi, quindi va usato con attenzione e consapevolezza.
Perché conviene a un’azienda promuovere la diversity? Per adempiere a un obbligo normativo o perché è una questione di business? Forse questa è la prima domanda a cui bisogna dare risposta. Se l’obiettivo è far leva sulle specificità dei singoli per massimizzare i risultati, allora dobbiamo creare la cultura della diversity all’interno delle organizzazioni. Questo significa far comprendere alle persone l’utilità del lavorare con le diversità e per farlo dobbiamo partire dalla riprogettazione di prassi e linguaggi…
Se avete voglia di raccontarci le vostre esperienze di diversity, scriveteci a scrivi@h2ogroup.it
Silvia Lepore
*Rielaborazione da fonti Istat
Comments are closed.


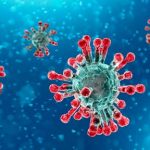

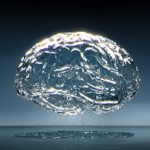

Commenti recenti